L’intelligenza artificiale a scuola: guida pratica per docenti consapevoli
Scritto da Giulia Dall'Aglio di Tecnologia Familiare - 26/09/2025
Scritto da Giulia Dall'Aglio di Tecnologia Familiare - 26/09/2025
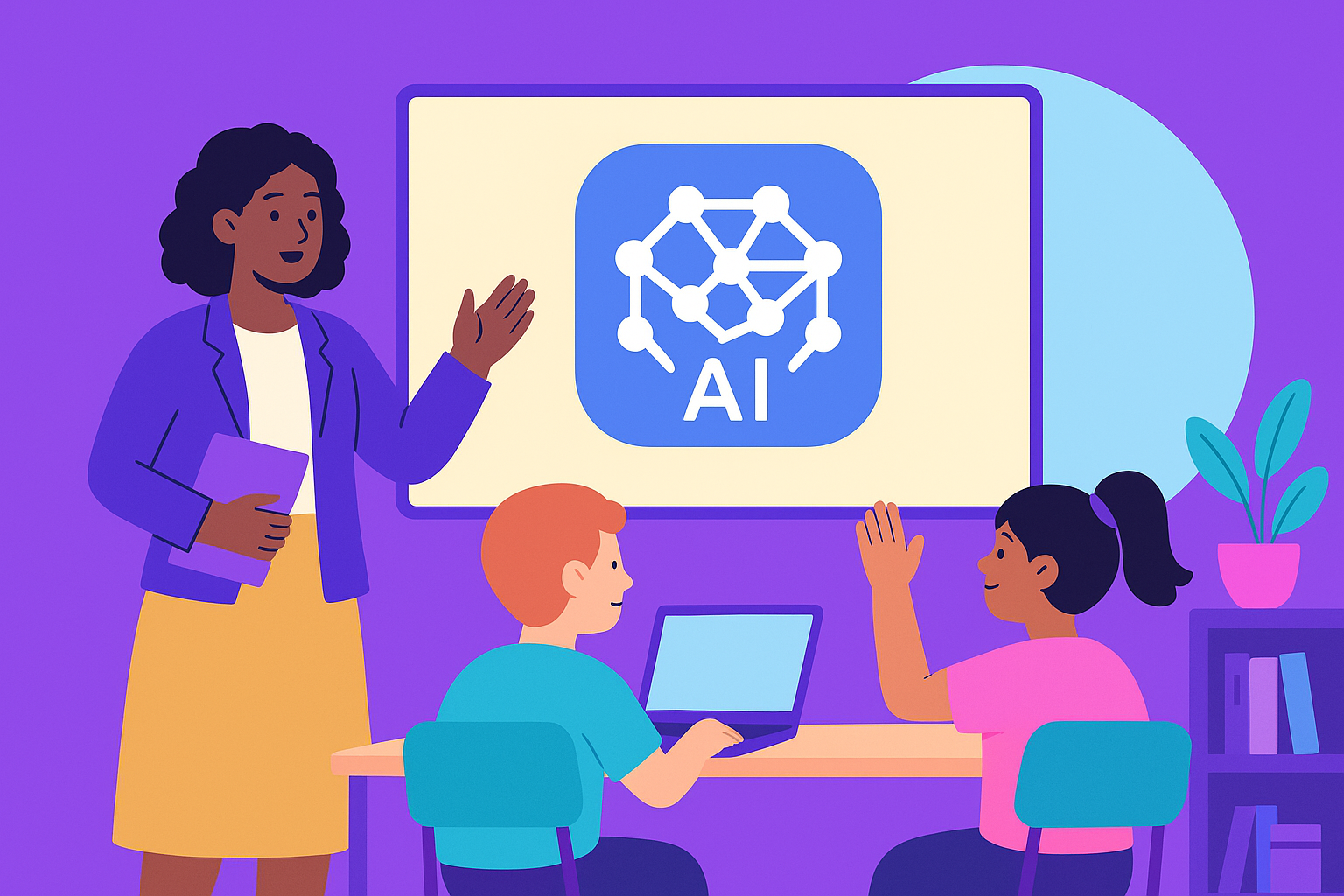
Un tempo la maggiore preoccupazione di un insegnante durante la verifica era controllare che gli studenti non copiassero dal compagno di banco. Oggi il miglior compagno di merende che uno studente possa desiderare avere vicino durante un compito in classe non è umano, è l’intelligenza artificiale.
Non si tratta più di capire se ha copiato dal compagno ma… come diamine ha fatto a riuscire a copiare da chat gpt?!
Non è solo una battuta, è un campanello che ci dice che qualcosa è cambiato: l’intelligenza artificiale non è più un futuro lontano, è un presente con cui i ragazzi si misurano già ogni giorno. È in classe con noi!
Come educatori e insegnanti, la tentazione è quella di reagire con divieti o giudizi: “Non serve a nulla”, “È come copiare”, “Non lo usare più”, “Ti frigge il cervello”.
Ma davvero questa è la strada migliore? O forse è arrivato il momento di chiederci come integrare l’AI nell’apprendimento, senza che diventi una scorciatoia sterile?
Per alcuni studenti l’AI è un vero alleato: semplifica testi complessi, traduce passaggi difficili, offre spiegazioni alternative quando quelle del libro o dell’insegnante non sono bastate.
In questi casi l’AI diventa un supporto concreto, che permette a chi è in difficoltà di non fermarsi davanti a un ostacolo e di sentirsi più competente, più sicuro di se. Pensiamo agli studenti con DSA, a chi studia in una lingua che non è la propria, o semplicemente a chi ha bisogno di un “punto di partenza” per poi rielaborare.
Per altri, invece, l’AI diventa una scorciatoia: la via rapida per finire i compiti in fretta, liberarsi dal pensiero e potersi dedicare a ciò che veramente dà soddisfazione. È un uso che può sembrare pigro, ma che in realtà spesso nasconde un bisogno reale: gestire la pressione, ridurre lo stress, trovare sollievo in un percorso scolastico che a volte appare troppo carico.
Agli occhi di adulti competenti, entrambe le reazioni sono comprensibili e risultano profondamente umane.
Lo studio richiede tempo, pazienza, concentrazione, e non tutti i ragazzi hanno le stesse risorse emotive e cognitive per affrontarlo. Ecco perché il problema non è tanto se usare l’AI, ma come usarla.
Quando viene usata come un trampolino, aiuta ad alzare l’asticella, stimola autonomia e curiosità, apre nuove strade di apprendimento. Quando invece diventa una stampella usata quando non c’è un bisogno reale, rischia di spegnere la “fatica utile”, quella che allena la memoria, la perseveranza, la capacità di organizzare un pensiero e sostenerlo con le proprie parole.
Le istituzioni europee parlano chiaro: l’AI va conosciuta, usata con trasparenza, integrata in percorsi educativi (Commissione Europea, Ethical Guidelines for Educators on AI).
Cosa significa? Come possiamo tradurre questo nella vita di tutti i giorni in aula?
Ecco alcune idee pratiche:
Ecco due esempi che possono funzionare bene:
Alcuni docenti temono che l’AI finisca per togliere senso al loro lavoro: se un algoritmo può riassumere un testo o scrivere un tema in pochi secondi, che bisogno c’è ancora dell’insegnante?
È una preoccupazione legittima, ma rischia di guardare solo la superficie. In realtà, proprio perché l’AI è capace di produrre risposte immediate, il ruolo dell’insegnante diventa ancora più prezioso.
Il valore non sta più soltanto nel verificare se il compito è “corretto”, ma nel guidare gli studenti a capire come ci sono arrivati.
Quali domande hanno posto all’AI?
Hanno accettato la risposta così com’era o l’hanno modificata?
Hanno instaurato un dialogo complesso con l’AI o le hanno semplicemente chiesto di fare un compito?
Con quali fonti hanno confrontato l’elaborato dell’AI?
L’anno integrato in qualche modo?
Perché hanno scelto una strada piuttosto che un’altra?
In questa prospettiva, l’AI non riduce ma amplia il raggio d’azione del docente, che diventa facilitatore di un processo di apprendimento più complesso e consapevole.
È l’occasione per spostare lo sguardo dal prodotto finale al percorso fatto per arrivarci. Non più soltanto: “quanto hai studiato?”, ma una domanda più ricca e formativa: “come hai imparato?”.
Accompagnare gli studenti a riflettere sull’uso che fanno dell’AI significa introdurli alla metacognizione, ossia alla capacità di osservare e valutare i propri processi di apprendimento. Ed è proprio questa abilità, oggi più che mai, a fare la differenza tra uno studente che sa solo ripetere nozioni e uno capace di imparare davvero per tutta la vita.
Naturalmente, non tutto è rosa. L’AI può sbagliare, inventare dati, trasmettere bias culturali. Può favorire chi ha più risorse digitali e lasciare indietro chi ha meno accesso. Per questo è importante stabilire cornici chiare: spiegare agli studenti che l’AI non è onnisciente, che le fonti vanno verificate, che la creatività e la responsabilità restano umane.
Probabilmente la sfida più grande è accettare che non abbiamo ancora tutte le risposte.
Obiettivamente non è la prima volta che la scuola affronta una rivoluzione. Internet, gli smartphone, i social hanno già cambiato il modo di cercare, comunicare, imparare. Ogni volta la scuola ha dovuto rimettersi in gioco, trovando un equilibrio tra rischi e opportunità.
L’arrivo dell’intelligenza artificiale non fa eccezione e ha una portata ancora più profonda perché non riguarda solo l’accesso alle informazioni ma promette (o “minaccia”, per qualcuno) di andare a modificare i nostri processi cognitivi e creativi.
Per questo la vera competenza del futuro non sarà limitarsi a saper usare l’AI, ma imparare a farne uno strumento di crescita critica e consapevole. Significa insegnare ai ragazzi a dubitare delle risposte pronte, a porsi le domande giuste, a riconoscere quando l’AI è un trampolino e quando invece rischia di diventare una stampella.
Ed è qui che la scuola resta insostituibile.
Perché nessun algoritmo può sostituire la capacità educativa di un insegnante: quella di dare senso, contesto, prospettiva, quella di trasmettere non solo conoscenze, ma anche il gusto di cercarle. E questo, oggi più che mai, è il cuore del nostro mestiere: formare persone capaci di imparare sempre (nonostante, e sopratutto grazie a) le tecnologie che avanzano.
Torna agli articoli